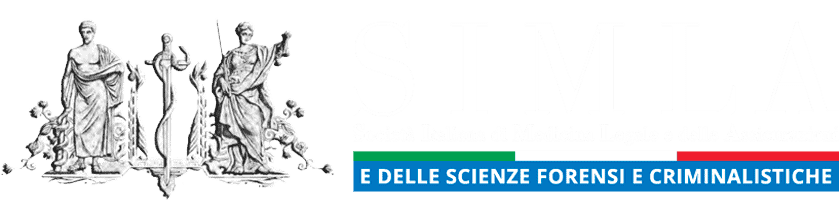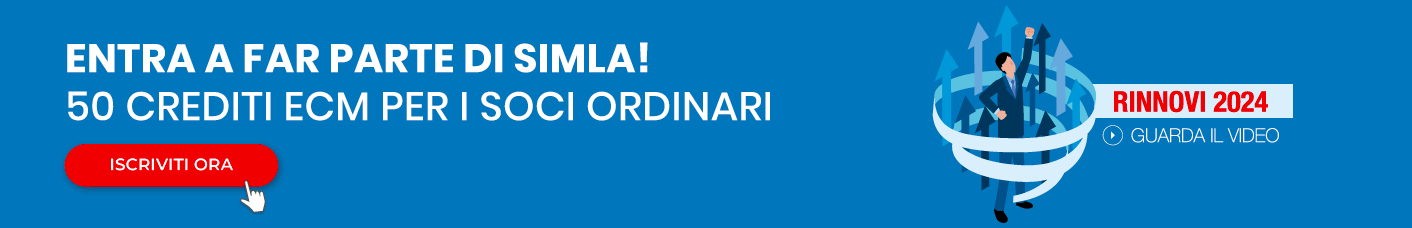Abstract
La tutela della salute del detenuto è stata argomento oggetto di ampio dibattito, a motivo della difficoltà di contemperare esigenze di certezza della pena con prospettive di umanizzazione della sanzione penale. Il contesto normativo di riferimento vincola, in particolare, la concessione degli istituti del differimento della pena e della detenzione domiciliare alla fumosa nozione di “gravità” delle condizioni di salute. La difficoltà valutativa medico legale in tale ambito, accentuata dall’emergenza Sars-Cov-2, si estrinseca in difformità applicative.
. . . .
Riferimenti normativi
Rinvio dell’esecuzione della pena detentiva
Gli articoli 146 e 147 del codice penale disciplinano gli istituti del rinvio obbligatorio e facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva.
Dal punto di vista medico legale, l’obbligo di differimento della detenzione era originariamente previsto nei casi in cui le condizioni cliniche del condannato fossero ascrivibili ad “AIDS conclamata, o grave deficienza immunitaria” ovvero a “malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione“.
Tra i requisiti strettamente sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio della sospensione facoltativa della detenzione è, invece, annoverata la sussistenza di “condizioni di grave infermità fisica”.
Successivamente la Suprema Corte ha scardinato l’automatismo del rinvio connesso alla sussistenza di deficit immunitari, restituendo ai Tribunali di Sorveglianza ampia discrezionalità e possibilità di commisurare la concessione del beneficio alle specifiche caratteristiche cliniche ed alle esigenze sanzionatorie.
Detenzione domiciliare
L’istituto della detenzione domiciliare è previsto dall’articolo 47ter dell’Ordinamento Penitenziario. È stato introdotto con la Legge 663/1986 ed è stato successivamente oggetto di modifiche.
Tra le condizioni previste dall’art. 47ter O.P., è previsto che l’esecuzione di una pena detentiva inferiore ai 4 anni possa essere svolta presso la dimora del detenuto in caso di “condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali“. È inoltre richiamata, per i soggetti di età superiore ai 60 anni, la condizione di inabilità, anche parziale. In merito, desta non poche perplessità interpretative il riferimento normativo all’abilità, attesa la stringente attinenza alla capacità lavorativa del termine secondo la consolidata dottrina medico legale.
L’art. 47ter, introdotto dalla Legge 231/1999, riconosce invece il beneficio della detenzione domiciliare in presenza del requisito, già esplicitato dall’art. 146 c.p., di “AIDS conclamata, o grave deficienza immunitaria“.
.
Elementi di valutazione
La grave deficienza immunitaria
Ciò premesso, la valutazione medico legale della grave deficienza immunitaria (ex art. 146 c.p. e art 47quater O.P.) è orientata da precisi parametri normativi, esplicitati dal Decreto del Ministero della Sanità del 7 Maggio 2001. In particolare, le condizioni immunologiche rilevanti ai fini del rinvio della esecuzione detentiva sono quelle caratterizzate da almeno uno dei seguenti parametri:
- numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mmc, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di 15 giorni l’uno dall’altro;
- indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.
Sul punto, appare opportuno riportare che il Karnofsky Performance Status è uno strumento per la valutazione comparativa del benessere e delle autonomie residue. In particolare, ad un punteggio di 50, corrisponde il paziente che necessiti di assistenza per l’espletamento degli atti quotidiani della vita, e frequenti cure mediche.
La malattia particolarmente grave
Per converso, l’art. 146 c.p. (Rinvio Obbligatorio dell’Esecuzione della Pena) identifica la malattia particolarmente grave nella “fase della malattia così avanzata da non rispondere più […] ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”. Tale locuzione richiama espedienti valutativi ancorati ad analisi della patologia dal punto di vista eziologico, prognostico, dell’iter classico di evoluzione, delle esigenze assistenziali e del rischio connesso ai trattamenti, nonché del pericolo in relazione alla probabilità di contagio.
La grave infermità fisica
Per quanto riguarda la grave infermità fisica ex art. 147 c.p. (Rinvio Facoltativo dell’Esecuzione della Pena), una fluida e articolata Giurisprudenza risalente principalmente agli anni ’80 e ’90, ha indirizzato la valutazione medico legale sul vaglio di due autonomi requisiti:
- La sussistenza di un rischio aggravato di detrimento alla prognosi quoad vitam, o di altre rilevanti conseguenze dannose, rilevabile dall’integrazione della infermità del detenuto con l’aumentata probabilità di eventi rilevanti dal punto di vista clinico, intrinsecamente connessa allo stato di detenzione;
- La possibilità di fruire, qualora in stato di libertà, di cure e trattamenti più efficaci rispetto a quelli praticabili in stato di detenzione.
Le condizioni di salute particolarmente gravi
Per l’art. 47ter dell’O.P., la connotazione di particolare gravità delle condizioni di salute del detenuto è consustanziale alla esigenza di contatti costanti con i presidi sanitari territoriali. In altri termini, e per estensiva giurisprudenza sul tema, rientrano in tale fattispecie una ampia gamma di alterazioni della funzionalità psico-fisica del condannato suscettibili di miglioramento attraverso prestazioni assistenziali reiterate ed erogate da presidi sanitari extracercerari.
Problematiche medico legali
La vaporosità della nozione di gravità è stata ricondotta alla volontà del legislatore di lasciare ampi margini di discrezionalità decisionale ai Tribunali di Sorveglianza. Tanto in relazione ad una volontà di personalizzazione del livello afflittivo e di umanizzazione della pena detentiva, nel pieno rispetto del dettame Costituzionale ex art. 27 c.3: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato“.
Un siffatto impianto normativo, unitamente all’assenza di riferimenti condivisi e consolidati di Letteratura medico legale per l’individuazione di criteri oggettivi, si è tradotto in una ampia disomogeneità applicativa a livello nazionale. La situazione illustrata, infatti, offre il fianco alla produzione di relazioni tecniche apodittiche, spesso redatte da consulenti tecnici non specialisti di branca e senza adeguata formazione medico legale.
A tanto si soggiunge il crescente ricorso dei Tribunali di Sorveglianza a richieste di certificazioni medico legali inerenti le condizioni di salute dei detenuti alle Aziende Sanitarie territoriali, in assenza di rituali conferimenti di incarico al singolo specialista. Tale espediente deriva dalla estensiva interpretazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, recentemente aggiornati dal DPCM 12 gennaio 2017. È evidente come una valutazione “ambulatoriale” della compatibilità carceraria mal si attagli ai complessi percorsi valutativi ed alle esigenze di obiettività ed uniformità dei giudizi.
.
In tale contesto, l’emergenza pandemica da Sars-CoV-2 ha ampliato ed esteso le ripercussioni delle difformità applicative. Di primo acchito, si è infatti registrata una estensiva mole di provvedimenti (LINK) di riconoscimento di detenzione domiciliare da parte dei Tribunali di Sorveglianza a fronte di condizioni di “fragilità” del detenuto e manifesta difficoltà da parte degli Istitituti Penitenziari ad attuare programmi efficaci di prevenzione del contagio.
In risposta a tale automatismo, si iniziano a rilevare episodici tentativi della Cassazione (LINK) di riportare la giurisprudenza sui binari della valutazione concreta del singolo caso. Appare quindi necessaria una articolata stima del rischio attraverso la valutazione della probabilità di contagio derivante dalle specifiche condizioni dell’ambiente carcerario, relazionata al danno concreto prospettabile sulla base delle condizioni di salute del detenuto.
Bibliografia essenziale
A. Carnevale, A. Di Tillio:“Medicina e Carcere”, Giuffrè Editore, Milano, 2006
A. Centonze: “L’esecuzione della pena detentiva e la ricostruzione sistematica della nozione di gravità delle condizioni di salute del detenuto“, Rassegna Penitenziaria e Criminologica, Numero 3-2006
A. Demori, D. Roncali, M. Tavani: “Compatibilità Carceraria, HIV/AIDS e “Malattia Particolarmente Grave“, Giuffrè Editore, Milano, 2001
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Vedi anche: Covid, diritti e medicina legale e COVID 19: interrogativi e risposte per il prossimo scenario di sanità pubblica