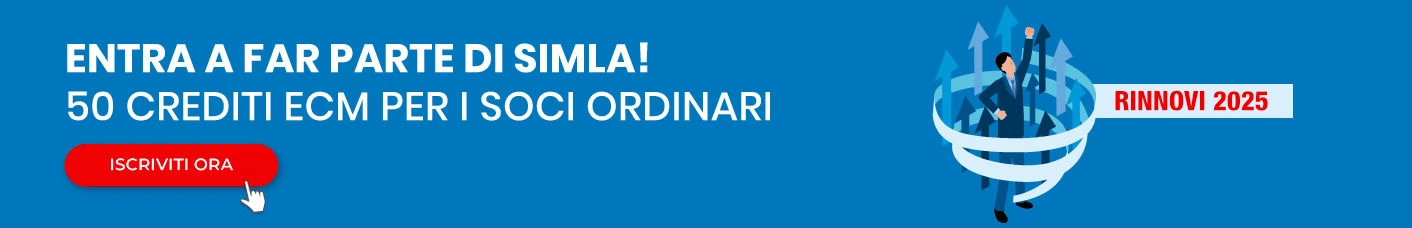In questo articolo del nostro Davide Santovito della Dott.ssa Carola Toffanin specialista in formazione della Scuola di Scuola specializzazione Igiene e Medicina Preventiva di Torino, presentata una sperimentazione nelle Aziende Sanitarie Piemontesi, condotta dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, che ha l’obiettivo di incentrare i percorsi di cura anche sulle scelte che il paziente decide di intraprendere secondo il principio di autodeterminazione pienamente sancito dalla 219/2017.
I cambiamenti culturali che hanno segnato il XX secolo hanno influenzato profondamente gli equilibri e le dinamiche sociali ad ogni livello, senza esclusione del rapporto medico-paziente.
Dai tempi della composizione del Corpus Hippocraticum e dell’Ars Medica fino agli albori del Terzo Millennio, la relazione tra curante e ricevente le prestazioni di cura è stata caratterizzata da una profonda asimmetria e da un accentramento del potere decisionale nella figura del medico. In accordo a questo modello “paternalistico”, la volontà del professionista sanitario prevarica non solo preferenze e desideri dell’assistito, ma la necessità di un suo esplicito consenso alla cura, essendo quest’ultimo desunto dal suo fidarsi e affidarsi al medico.
L’autodeterminazione del paziente sancita dalla Legge
Nel corso del XX secolo tale impianto relazionale ha ceduto il passo ad un approccio “contrattualistico” che, valorizzando l’autonomia del paziente, ricalibra gli equilibri del rapporto di cura e sancisce una più equa distribuzione del potere decisionale.
La relazione tra medico e malato si configura dunque come una alleanza, all’interno della quale la sinergia delle parti permette il raggiungimento del fine condiviso di buona riuscita del percorso di cura. Venuta meno la supremazia decisionale del medico, l’acquisizione del consenso del paziente diventa una prerogativa imprescindibile all’erogazione di qualsiasi prestazione sanitaria.
La necessità di affermazione del diritto all’autodeterminazione del soggetto nel campo sanitario trova espressione nell’art. 32 della Costituzione e, in seguito a numerosi pareri giurisprudenziali, è stata formalizzata nella legge 219/2017 che disciplina la materia del consenso informato e delle disposizioni anticipate di trattamento.
Nella formulazione di tale legge emerge la volontà del Legislatore di sottolineare il ruolo fondamentale del paziente all’interno del percorso di cure, il cui coinvolgimento nei dei processi decisionali clinici rappresenta non solo un atto dovuto, ma apre la strada ad una diversa visione dell’organizzazione dei servizi sanitari, che sia centrata sulla persona e ne tenga in considerazione preferenze e valori.
La Rete Internazionale degli Ospedali e dei Servizi Sanitari per la Promozione della Salute (HPH)
Di un tale approccio ai percorsi di cura si fa sostenitrice la Rete Internazionale degli Ospedali e dei Servizi Sanitari per la Promozione della Salute (HPH), una comunità di oltre 600 ospedali che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria attraverso una ridefinizione dell’assetto strutturale delle organizzazioni sanitarie, incorporandovi un attivo coinvolgimento non solo dei pazienti e del personale, ma anche delle famiglie e dell’intera comunità.
In quest’ottica, gli Standard HPH 2020 rappresentano uno strumento di autovalutazione sviluppato per supportare le strutture nell’identificazione di punti di forza e aree di miglioramento della propria realtà sulle quali intervenire per consentire una più efficace realizzazione degli obiettivi della rete HPH. Lo standard 3 (“Migliorare l’assistenza sanitaria centrata sulla persona e il coinvolgimento dei cittadini che afferiscono ai servizi”) in particolare è stato il fulcro del lavoro di un gruppo di ricerca parte dell’unità piemontese operante nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2020-2022 “Trasformazioni sociali e la crisi degli esperti”, volto ad indagare i profondi mutamenti che hanno investito la figura dell’esperto, anche nella sua funzione sociale, all’interno delle società dominate dal progresso tecnologico.
Il progetto piemontese
Nello specifico, il progetto di ricerca relativo allo standard 3 HPH, guidato dalla Prof.ssa Patrizia Lemma con il supporto della Prof.ssa Maria Michela Gianino e del Prof. Giacomo Scaioli e la partecipazione della Scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva (Dott.ssa Giulia Barbera, Dott. Alessandro Mara, Dott.ssa Andreea Mihaela Butnaru, Dott.ssa Carola Toffanin) dell’Università di Torino, si pone l’obiettivo di elaborare criteri osservabili e oggettivabili che consentano di definire la capacità delle strutture di coinvolgere il paziente all’interno dei processi decisionali dell’organizzazione che impattano sul proprio stato di salute. La verifica di tali criteri permetterà alle aziende sanitarie di individuare criticità e aree di possibile miglioramento verso un percorso di accreditamento all’eccellenza con cui incrementare l’engagement e l’integrazione del paziente nei meccanismi di programmazione, progettazione e implementazione dei servizi sanitari.
Inoltre, grazie alla costruzione di una comunità di pratica che ha visto coinvolte alcune aziende sanitarie piemontesi (ASL Alessandria, ASL Cuneo 2, ASL Torino 4, ASL Torino 5, ASL Verbano Cusio Ossola, AO Ordine Mauriziano, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino- Presidio CTO), il gruppo di ricerca mira a realizzare una raccolta delle migliori pratiche attuate nelle strutture che promuovono una cura centrata sulle persone.
La sperimentazione, che ha visto anche la partecipazione di una giuria di cittadini chiamata a deliberare circa i criteri sviluppati, si è conclusa ad inizio dicembre con la condivisione, in occasione di una giornata di formazione, delle esperienze di applicazione dello strumento elaborato da parte delle aziende sanitarie coinvolte.