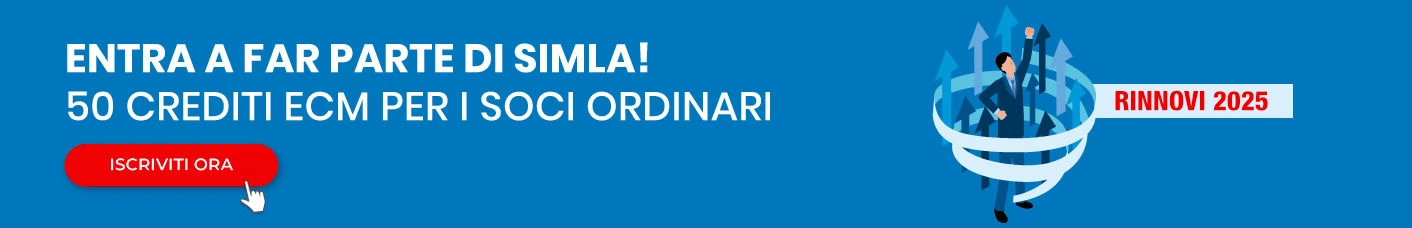Sono una donna, sono stata per anni referente per il mio Dipartimento del gruppo Gender & Equalitydell’Ateneo milanese, ho scritto molto sulla violenza contro le donne.
Tutto questo non lo scrivo per pavoneggiarmi ma per accreditarmi come persona che non dovrebbe essere considerata insensibile al problema della violenza contro le donne.
Sono però anche garantista e criminologa, e da questi punti di vista la proposta di inserire nel codice con l’art. 577-bis il femminicidio quale titolo autonomo di reato mi desta delle perplessità.

La discriminazione non caratterizza un solo tipo di delitto
Poiché ho la pessima abitudine di parlare di quello che so, sugli interrogativi giuridici che la proposta di un reato di femminicidio suscita sarebbe meglio parlassero i giuristi, che infatti ne hanno parlato[1], limitandomi per quanto mi riguarda a richiamare alcuni punti, primo fra i quali l’art. 3 della Costituzione che scrive dell’uguaglianza dei cittadini “senza distinzione di sesso”. Il testo del DDL n. 1433 presentato al Senato recita però: “Chiunque cagiona la morte di una donna[2] quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo”.
Se poi l’introduzione di un nuovo reato dovesse puntare sulle motivazioni di discriminazione, di odio, per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o l’espressione della sua personalità, ne dovremmo introdurre molti di nuovi reati, a cominciare almeno dallo “omocidio”, neologismo coniato in analogia al termine “femminicidio”, che designa un delitto contro un omosessuale in quanto tale.
Un cenno “giuridico” da fare è che a pene massime e al massimo della pena in caso di femminicidio si può giungere pur senza introdurre una nuova fattispecie di reato, posto che la pena per l’omicidio raggiunge l’ergastolo se esso è commesso nei confronti “del coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva”.
Overcriminalization, ansiolitici sociali e deterrenza
Sempre ai giuristi lascio, pur ricordandola, la critica all’ipertrofia del diritto penale ovvero l’overcriminalization, la “fabbrica di nuovi reati [che] lavora a pieno regime”[3].
Dicevo che sono però anche una criminologa, e di criminologia qualcosa so, posso mostrare credenziali.
Ebbene, cosa si vuole ottenere introducendo questo reato nel codice? (oltre a un demagogico consenso e un “ansiolitico sociale”[4], intendo).
Una delle funzioni della pena è quella deterrente: il cittadino si astiene dal commettere reati per timore appunto della sanzione. A parte che, come non ci si stancherà di ripetere, si può comminare il massimo della pena anche con l’attuale campionario di reati, c’è da aggiungere che per sapere quale potrebbe essere l’effetto deterrente dobbiamo sapere chi e perché commette “femminicidio”.
Quali effetti sui diversi tipi di autori dello specifico reato
Ci sono coloro -benché pochi- che hanno commesso il reato a causa di malattia mentale: sarebbero stati o saranno trattenuti dall’introduzione del reato di femminicidio?
C’è chi ha ucciso o comunque è stato violento sulla base di un serio problema di dipendenza dalla partner, senza la quale non riesce a concepire di poter vivere. Musil lo dice meglio di me: “I teneri sentimenti della dedizione maschile sono infatti simili al brontolio di un giaguaro che ha fra le zampe un pezzo di carne e non tollera di essere disturbato”. Costoro abbisognerebbero di una risocializzazione che insegni a distinguere l’amore dal possesso, ben difficilmente sarà la previsione del nuovo reato a trattenerli.
Infine, ci sono quei casi -sono la maggior parte- in cui l’omicidio è il dramma finale di una lunga storia di maltrattamenti, prepotenze, violenze, accompagnate da una salda sottocultura di discriminazione di genere e di sostegno alla violenza, che a sua volta trae alimento dalla messa in atto di auto-giustificazioni per il comportamento deviante che consentono al soggetto di neutralizzare il conflitto con la morale e dunque il rimorso. Anche qui servono interventi di educazione e socializzazione, costoro sono a conoscenza dell’esistenza del reato di omicidio, e anche costoro non saranno fermati dal fatto che esista uno specifico reato di femminicidio, sempre ammesso che lo vengano a sapere prima.
So, come tutti i criminologi sanno, che l’aumento delle pene, a cui l’introduzione del femminicidio vorrebbe condurre, non serve da solo a diminuire un reato, quantomeno non serve se la motivazione non è, non è “solo” la paura della pena.
Qualche dato statistico-epidemiologico sul femminicidio
La relazione al Disegno di legge che vuole introdurre il nuovo reato, al suo esordio, scrive della “estrema urgenza criminologica del fenomeno”, frase che mi ha fatto per un momento deporre la mia abituale mansuetudine. L’uccisione di donne da decenni è diminuita. Per non tediare snocciolando dati ci si limiterà a dire che passano dai 199 del 2000 ai 113 del 2025. Omicidi di donne non significa femminicidi, ma l’ISTAT ci informa che dall’analisi di 417 sentenze dal 2012 al 2016 i femminicidi costituiscono l’85% delle uccisioni di donne, e poiché negli ultimi anni quelle uccise da partner ed ex partner -cioè dove si annidano con più probabilità i femminicidi- costituiscono più di questo 85% possiamo dire che omicidi di donne è quasi sinonimo di femminicidi.
Il fatto che siano in diminuzione non basta a confortarci, ce ne fosse solo uno sarebbe scandaloso. Anche le stragi, a Dio piacendo, sono in diminuzione, il che non suggerisce indulgenza. Però è difficile pensare che la diminuzione sia dovuta all’inasprimento delle pene o all’introduzione di nuove fattispecie di reato, che infatti non c’è stata, è più verosimile ritenere che sia dovuta a un mutamento culturale: se il fenomeno che qui ci occupa ha radici culturali, quelle sono da recidere.
Per gli idealisti ci sarebbe poi la funzione rieducativa, anch’essa citata nella Costituzione -testo ultimamente un po’ demodé- secondo cui le pene “devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Le pene e la rieducazione
Siccome una laurea in Giurisprudenza oramai l’ho presa e non me la si può togliere, mi permetto di essere in parziale disaccordo con i giuristi quando rifiutano con fermezza ogni funzione “pedagogica” del diritto penale, o almeno del suo esito carcerario.
L’intervento del sistema della giustizia nel caso delle violenze contro le donne non è da sottovalutare: ha un effetto specialpreventivo, nel senso che il violento è messo per un certo periodo in condizioni di non nuocere; ha, forse soprattutto, un effetto generalpreventivo, perché sottolinea il fatto che l’abuso è sbagliato, censurabile, criminale, il che non è messaggio da poco in una cultura che conserva residui di autoritarismo e discriminazione di genere, ed in cui fino a non molto tempo fa l’intervento anche delle agenzie di controllo formale sollecitava a “lasciar correre”, a non mettere a repentaglio a nessun costo l’unità della famiglia; ha un effetto insieme specialpreventivo e generalpreventivo nel senso che addita all’autore le negatività e la nocività del proprio comportamento.
Lo stigma penale serve dunque a ricordare a chi ancora non ne sia sufficientemente convinto che si tratta di comportamenti inaccettabili.
Effetti del solo intervento giudiziario e carcerario
D’altro canto, il solo intervento giudiziario e carcerario rischia di lasciare il soggetto pressoché immutato, e magari peggiorato perché se la condanna può essere l’occasione per confrontarsi con il fatto che il comportamento è sbagliato, senza un raffronto più approfondito con valori diversi e con quello che si agita nel proprio animo, può anche suscitare sentimenti di ribellione, di –per quanto mal riposta- ingiustizia subita, addirittura di vendetta.
Tutto questo con i già esistenti strumenti sanzionatori. In quest’ambito -e non solo in questo- le pene dunque ci vogliono, ma poiché le pene per la violenza già ci sono, non si vede come possa intervenire il nuovo reato per la “responsabilizzazione”, per una educazione o rieducazione, per una socializzazione o risocializzazione, anche precoci, che però sono lunghe, impegnative, costose.
Un esempio? Nell’Ateneo milanese, nonostante gli sforzi della Medicina Legale, non si è potuto continuare il progetto di trattamento per i partner violenti, progetto laborioso, non immediato nei risultati, dispendioso.
Introdurre il reato di femminicidio invece è veloce, sbrigativo, non costa niente.
E se anche non servisse a niente?
[1] Fra gli altri: Compagna F., Femminicidio, o il diritto penale della propaganda, Il Foglio, 10 marzo 2025; Donini M. perché non introdurre un reato di femminicidio che c’è già. SOS contro un’emergenza antiumanista e non femminista, Sistema Penale, 3 aprile 2025; Fiandaca G., Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio, Il Foglio, 13 marzo 2025; Melis V., Perché il reato di femminicidio non sta in piedi, Il Foglio, 13 marzo, 2025; Menditto F., Riflessioni sul delitto di femminicidio, Sistema Penale, 2 aprile 2025; Puggiotto A., La mimosa all’occhiello del populismo penale (prima parte), Sistema Penale, 2 aprile 2025.
[2] Il corsivo è mio.
[3] Pugiotto A., cit.
[4] Fiandaca G. cit.